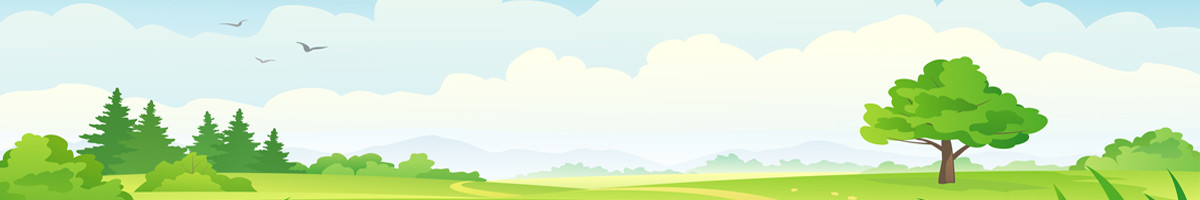QUANDO, COME E QUANTO L’ABITARE PUO’ ESSERE TERAPEUTICO: UN’ESPERIENZA
Introduzione
Nasco professionalmente all’interno delle comunità, educative prima terapeutiche dopo.
Mi ha da sempre affascinato la possibilità che “l’abitare” possa svolgere funzioni terapeutiche: quando, come e quanto il vivere la quotidianità con soggetti portatori di grande sofferenza psichica possa costituirsi come campo di contenimento; contenitore in cui poter elaborare eventi traumatizzanti; spazio fisico e mentale di accoglimento di proto-emozioni, di pensieri non pensabili.
In comunità, sia gli operatori che gli ospiti, sia l’equipe clinica che il personale ausiliario “co-costruiscono” e “co-generano” il campo, il contesto in cui si muovono; di più, le evoluzioni, i cambiamenti all’interno della struttura vengono influenzati non soltanto dalle dinamiche interne ma anche dai rapporti con l’esterno, con un territorio che avvolge ed interagisce con il complesso mondo comunitario.
Le proiezioni dei pazienti, quelli del personale, le difese attivate, i sogni, i pensieri onirici della veglia animano l’istituzione e richiedono la necessità di un continuo lavoro di filtro, di significazione, di interpretazione che non può esaurirsi all’interno della stanza d’analisi ma che trova applicazione in diversi contenitori: equipe cliniche, riunioni organizzative, incontri individuali, laboratori; ma anche lungo i corridoi dell’istituzione, in cucina durante la preparazione dei pasti o nelle stanze durante la fase di addormentamento.
E’ proprio dalla possibilità, in un contesto gruppale, di integrare e dare senso alle diverse immagini frammentate che gli operatori portano del paziente e della situazione in cui operano, che prende le mosse il lavoro di costruzione e/o riparazione del mondo interno degli utenti da parte dell’istituzione comunitaria.
Una strada verso il mare
Quanto sarebbe bello se, per ogni mare che ci aspetta, ci fosse un fiume, per noi. E qualcuno- un padre, un amore, qualcuno- capace di prenderci per mano e di trovare quel fiume- immaginarlo, inventarlo- e sulla sua corrente posarci, con la leggerezza di una sola parola, addio. Questo davvero sarebbe meraviglioso. Sarebbe dolce la vita, qualunque vita. E le cose non farebbero male, ma si avvicinerebbero portate dalla corrente, si potrebbe prima sfiorarle e poi toccarle e solo alla fine farsi toccare. Farsi ferire, anche. Morirne. Non importa. Ma tutto sarebbe, finalmente, umano. Basterebbe la fantasia di qualcuno. Lui saprebbe inventarla una strada, qui in mezzo al silenzio, in questa terra che non vuole parlare. Strada clemente, e bella. Una strada da qui al mare. (A. Baricco)
La Comunità di cui sono responsabile si trova in un piccolo paese fra le risaie piemontesi. La grande struttura, disposta su due piani, con davanti un pino ed un ficus che raggiungono il tetto, danno la sensazione di “casa”. Nel giardino antistante ci sono parcheggiate bici, più o meno funzionanti; il cancello della ringhiera che circonda la struttura è chiuso ma il portone d’entrata è quasi sempre aperto per il continuo andirivieni di operatori e ragazzi. Grandi finestre senza sbarre, velate da solari tende gialle, si affacciano su un giardino che presenta spesso i segni della lotta per la vita che caratterizza la Comunità.
Mi sembra che arrivando ci si possa sentire pervadere da un senso di fiducia, di reale speranza che in questo luogo ragazzi sofferenti possano compiere un’esperienza “sufficientemente buona”, significante.
La Comunità è una struttura di accoglienza per preadolescenti ed adolescenti affetti da gravi patologie psichiatriche dell’età evolutiva. La maggior parte di coloro che vengono da noi hanno vissuto abusi sessuali e maltrattamenti; hanno sperimentato interruzioni traumatiche nei rapporti familiari e, di conseguenza, l’equipe si trova a confrontarsi con problemi relativi alla fiducia ed all’attendibilità, con paure ed angosce, sin dal momento del primo contatto con il ragazzo.
La convinzione su cui si poggia il lavoro in comunità consiste nel fatto che ogni singola interazione con ogni singolo ragazzo ha un significato “terapeutico”, e che la “terapia” non è confinata alle sedute individuali o di gruppo, ma ha luogo informalmente a pranzo, nei corridoi, al momento del risveglio e dell’addormentarsi, in tante diverse e possibili circostanze.
Scene di vita quotidiana: Giorgia
<Giorgia, in seguito ad un diverbio con un’educatrice per il rispetto di una regola della Comunità, sferra un pugno alla porta della cucina e scappa. E’ pomeriggio, sono circa le 17.45, i ragazzi si ritirano nelle proprie stanze; c’è un inquietante silenzio lungo i corridoi della Comunità.
Si mettono in atto le procedure di emergenza: l’OSS in turno raccoglie i frammenti della porta, copre il buco con un poster e telefona al falegname di “fiducia”; un operatore perlustra le strade vicino alla struttura; gli altri due operatori si occupano dei ragazzi.
Alle 18.30 riceviamo una telefonata dal primario della pediatria dell’ospedale della città vicina, che ci comunica che Giorgia è in reparto: piange e chiede di essere aiutata con una iniezione di calmante. Assicuro il primario che entro quindici minuti sarei stata da lui per riprendere la ragazza.
Insieme ad un operatore ci rechiamo in ospedale; al mio arrivo, trovo Giorgia piangente, seduta a terra. Quando mi vede si alza, il volto bianco dalla collera, si dirige verso di me minacciosa e pone le sue mani intorno al mio collo come a volermi soffocare.
Dopo un iniziale sgomento, incontro Giorgia con lo sguardo, sento che non stringe, le sue dita tremano; sento la sua paura, la sua disperazione; vivo la sua lotta interna fra la vita e la morte.
Faccio un cenno al primario ed all’operatore che è tutto a posto e chiedo a Giorgia cosa stia facendo; la guardo negli occhi, senza sfida, ma con consapevole ed autentico desiderio di condividere il terrore che la attanaglia.
Lei allenta la presa, piange, non mi guarda.
“Andiamo in comunità. Vieni con me.” Le dico, offrendole un fazzoletto di carta.
Adesso posso affidarla all’operatore, al quale chiedo di uscire dal reparto per comprarle qualcosa da mangiare, mentre io mi occupo di fornire le adeguate spiegazioni al primario.>
Pur avendo ormai 15 anni e presentando una muscolosa corporatura, Giorgia sembra provare vissuti primitivi, caratterizzanti le prime fasi dello sviluppo del bambino: angoscia di morte, confusione percettiva, difficoltà di discriminare, minaccia di disintegrazione.
Giorgia può placare la sua collera quando si sente contenuta in uno sguardo non giudicante; quando la sua paura, la sua disperazione può essere “tenuta”, resa più digeribile: “Se il neonato sente che sta per morire, può indurre nella madre il timore che egli stia morendo. Una madre equilibrata può accogliere queste sensazioni e rispondervi in modo tale che il neonato senta di ricevere nuovamente in dietro la propria personalità spaventata, ma in una forma per lui tollerabile.”(W. Bion)
Ancora, un ruolo determinante nella risoluzione dell’emergenza è determinato non tanto dalle parole, ma dall’intonazione della voce, dal mio corpo che non si libera dalla stretta al collo, dalla mia postura e soprattutto dal mio sguardo:“Quando guardo sono visto, e quindi esisto.”(D. Winnicott)
Dopo 2 anni di permanenza in Comunità Terapeutica, Giorgia ha conseguito un titolo di studio per panificatore; è in grado di tollerare la frustrazione e di farsi aiutare nel trovare significati agli accadimenti della propria esistenza. Giorgia oggi può avere fiducia e sperare, movimenti emotivi prima impensabili!
Dott.ssa Giuseppina Calvo, Psicoterapeuta presso Comunità per Adolescenti e Consulente Tecnico d’Ufficio presso Tribunale di Busto Arsizio (VA)